Della coscienza
di questi tempi disarticolati e strani, recupero un capitolo del mio Manuale di Filosofia morale, edito da Il Quadrivio nel 2006, con il titolo Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto (Rom 7, 14), famoso detto di san Paolo.
Cum-scientia è scienza di sé, scienza del guardarsi dentro. In greco suona, infatti, sin-èidesis etimologicamente identica al termine latino e quindi a quello italiano. E’ una delle parole di cui più si usa e abusa, spesso travisandone almeno in parte il vero significato.
Nel linguaggio corrente contemporaneo coscienza si può intendere in due modi principali: il primo di accezione morale, cioè “avere una coscienza”, che è sinonimo di possedere dei principi etici come norma dei propri comportamenti; il secondo di accezione psicologica e cognitiva, come “essere coscienti di”: cioè essere consapevoli. In questo secondo caso, “coscienza” assume quasi il significato di conoscenza, e senz’altro, in toto, quello di consapevolezza. In questa riflessione cercheremo soprattutto di approfondire l’accezione più propria di coscienza, cioè la prima.[1]
Vediamo: prima della coscienza intesa come facoltà umana di autovalutazione morale, secondo Aristotele[2] e Tommaso d’Aquino[3], che la denomina “ordinatio rationis“: uso dell’intelletto secondo la ragione del fine, vi è la cosiddetta sinderesi, cioè la facoltà di agire necessariamente verso il “bene”, seguendo la scienza dei “primi principi pratici” posti nell’intelletto, o ragione. Su ciò non è d’accordo tutta la scuola nominalista, nata dalle riflessioni del beato Duns Scoto e di Guglielmo d’Ockam, l’occasionalismo di Malebranche, e la casuistica seguita al Concilio di Trento; non è d’accordo Kant, che è il più famoso moralista moderno, ma non lo è per i presupposti gnoseologici; non sono d’accordo le teorie utilitariste classiche (da Hume in poi) e attuali. Tutte queste scuole di pensiero, infatti, ritengono che l’adesione al bene appartenga piuttosto alla sfera della volontà: “devo fare il bene perché devo“,[4] oppure “devo fare il bene (quale bene? ndr) perché mi conviene“.[5] Ma, non tanto stranamente, sia pure con parole diverse, comincia ad essere di nuovo d’accordo con san Tommaso (e quindi con Platone, Aristotele e sant’Agostino) molta della filosofia morale contemporanea, anche in parte quella laica[6]. Evidentemente il relativismo etico e il cosiddetto “pensiero debole” cominciano a preoccupare più d’un uomo pensoso. Per proseguire però si deve brevemente riflettere sui concetti di “partecipazione” e di “bene”. Sono ambedue concetti denominati “trascendentali”, vale a dire diversamente riferibili a più soggetti: essi infatti si devono intendere in modo non univoco, ma analogo. Per “partecipazione” si concepisce un qualcosa che può appartenere con intensità diversa a due soggetti diversi, come ad esempio la “vita” negli esseri viventi vegetativi (piante) e nei sensibili (animali). Per “bene” si intende tutto ciò che può essere raggiunto come fine, indipendentemente dall’essere o meno ordinato al fine vero del soggetto desiderante: cioè, è bene, intanto, ciò che si desidera conseguire. La sinderesi agisce a questo livello. Al livello successivo, più alto, si pone il livello della coscienza morale, che è chiamata a scegliere sulla base della finalità propria del soggetto. E’ a questo punto che resta aperto, ora più che mai, il dibattito su ciò che sia “coscienza morale”. In generale si possono individuare due posizioni: vi è che sostiene che l’uomo, ponderando di sé in generale, opera una scelta morale globale che si può definire “opzione fondamentale”. A seguito di questa scelta si potrebbero considerare come meramente accidentali (nel senso proprio di non-costituenti-la-sostanza dei fatti e delle cose) anche le azioni più gravi (o peccaminose), poiché il soggetto avrebbe operato una scelta per il bene, cui comunque, in ultima istanza tenderebbe. E’ la morale del “siamo tutti salvi”, basta la fede (Fede), un poco neo-luterana, inclusiva, e un poco… buonista. Vi è, per contro, chi sostiene che, anche ammettendo un’opzione fondamentale per il bene, questa debba essere sempre vigilata e sostenuta da azioni buone, perché quelle cattive la ferirebbero talora, forse, in modo “mortale”,[8] laddove vi sia: materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso.
Forse è il caso di considerare seriamente la pervasività della fallibilità umana, e la facile adesione dell’uomo al male.
Approfondimento tematico – Quell’oscura presenza
Nei giorni di ciascuno di noi, quando il silenzio ci aiuta nella riflessione interiore, quando si riesce ad abbandonare lo strepito quotidiano, sorge dalle profondità dell’anima un fiotto irrefrenabile, come una colata di lava incandescente, come un torrente reso turbinoso dalla piena. Pensieri, rimorsi, ipotesi, pentimenti, moti d’ira raffrenati, intuizioni… e poi é come se, su tutto questo materiale confuso, si ergesse un giudice pacato e severo: la nostra coscienza. Per giorni, settimane, mesi, a volte anni, essa tace, avvolta nell’oscurità dell’anima, nel torpore di una volontà ferita, ma a un certo punto essa riemerge, senza prepotenza, senza iattanza, in punta di piedi, quasi per non disturbare. E allora lentamente illumina l’ombra profonda che c’è dentro di noi, prima con barlumi infinitesimi, che ci permettono di intravedere qualcosa, e poi con sempre maggiore vigore ci mostra la nostra condizione. Fino a che non riusciamo a vedere con chiarezza ciò che prima era avvolto dalle caligini, avviluppato dalle panie della nostra cecità. Ci mostra il male che è dentro di noi, la nostra superbia e la nostra cupidigia, madri maligne delle cattive azioni che abbiamo compiuto. Siamo stati superbi e dunque abbiamo smesso di ascoltare, di imparare, di avere attenzione per noi stessi e per gli altri, travolti da quella che pensavamo fosse una vera, sana attenzione per noi stessi. Siamo stati cupidi e dunque abbiamo desiderato per noi beni sbagliati, finiti, disordinati, pensandoli adatti alla nostra vita. Abbiamo messo la sordina alla retta ragione scambiando il male con il bene.
Come impostare allora la vita, allorquando, alla fine di un lungo tunnel male o punto illuminato, si trova la via d’uscita? Non certo pensando di avere sconfitto tutta l’umana fragilità che è in noi, che ci costituisce, almeno parzialmente. Essa è parte non eliminabile della nostra struttura personale, e ci rende cagionevoli, bisognosi di aiuto. Essa è uno specchio nel quale ritrovare la via dell’umiltà, che si oppone alla superbia come il bene al male. Il problema che ci sta di fronte è come riuscire ad armonizzare ricomponendo le nostre straordinarie facoltà di esseri intelligenti, cioè come ricostruire la nostra identità creaturale.
Lo sforzo è grande e non privo di incertezze, cadute, ripensamenti, stanchezza. La perseveranza è la virtù da invocare e praticare. Proprio quando sembra che non ce la facciamo, che l’impegno sia troppo grande, smisurato, allora capita che ci accorgiamo di avere fatto un passo avanti, magari impercettibile. Ciò che fino a qualche tempo prima ci pareva nebuloso e incerto, comincia a stagliarsi alla nostra coscienza con un certo nitore.
Ecco: la cosa giusta da fare è questa. Lì mi stavo sbagliando… La coscienza non ha voce stentorea, più spesso fa fatica a varcare la soglia della nostra percezione interiore, perché siamo affannati a fare mille cose, frastornati da innumerevoli interessi e incombenze. E non ci mettiamo in ascolto.
Ma la voce (la coscienza) è resistente. E capace di emergere nei momenti di silenzio, quando finalmente fermiamo il nostro attivismo e ci predisponiamo al riposo. Occorrerebbe andarle incontro ogni giorno. Donarsi momenti di contemplazione e di cura del nostro spirito, fermandoci a osservare le cose, gli altri, il mondo, ma da fermi. In silenzio. E valutare le nostre azioni, soppesarle, confrontarle, chiedendoci se sono state congrue con il nostro esistere, se sono state buone, per noi e per gli altri.
I credenti di tutte le religioni e i seguaci di tutte le etiche dei valori lo chiamano esame di coscienza, o giù di lì, ciò che è il solo modo che permette a quella presenza avvolta nella nostra oscurità interiore, di uscire dalla latenza cui spesso la costringiamo, per illuminare finalmente la nostra via di una luce pura.
E’ dunque nella mia coscienza che si fa presente, in qualche modo, la normatività morale. La intendiamo qui dunque come
“quell’atto della ragione pratica che, alla luce dei primi principi del bene, della scienza etica e dell’esperienza personale illumina il soggetto su ciò che deve fare o evitare hic et nunc nella sua personalissima e irripetibile situazione.”[9]
Il giudizio etico della coscienza è allora la norma prossima della moralità e dell’obbligazione di una determinata azione dell’agente razionale (l’uomo).
E’ a questo punto che dovrebbe scattare, quell’atto che Aristotele chiama proàiresis, cioè la decisione per il bene proprio dell'”ente”, il quale dovrebbe essere riconosciuto quasi per connaturalità, per simpatia, per esercizio di retta ragione.[10]
Un’altra questione (anche questa sarà approfondita più oltre) concerne il rispetto dovuto alla coscienza erronea. Per coscienza erronea si intende quell’atto di coscienza che non persegue il fine dell’ente secondo la sua propria natura, ma non per cattiva volontà, piuttosto per una qualche forma di ignoranza momentaneamente invincibile. Nonostante tale atto sia erroneo, esso va rispettato, fino a che un approfondimento illuminato dalla retta ragione non porti il soggetto a cambiare la propria decisione.
[1] Interessante potrebbe essere esplorare la distinzione sartriana fra l’en-soi e il pour-soi, che approfondisce il tema dello iato esistente fra essenza dell’essere, o fatticità, e potenzialità dell’essere, o trascendenza: luogo dove si dibatte anche il conflitto naturale fra coscienza irriflessa e coscienza riflessa o “conoscenza”.
[2] Etica Nicomachea, VII, VIII
[3] Summa Theologiae, I-II, q. 19, art. 2
[4] è la deontologia kantiana
[5] il casuismo gesuitico e l’utilitarismo empirista anglosassone
[6] Cfr. in Galimberti U., I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, 2002
[7] Possiamo intendere il termine sia nel senso comune che nel senso teologico di peccato.
[8] Poppi A., Per una fondazione razionale dell’etica, cit., Studium, Padova 1994
[9] Cfr. Tommaso d’Aquino, De veritate, q. 17, a. 1
Post correlati

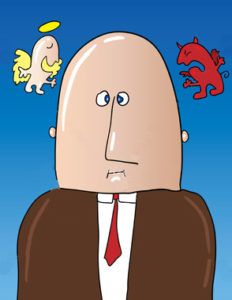
0 Comments